Il mondo ha bisogno di più compassione


Scritto e verificato la psicologa Valeria Sabater
Il mondo ha bisogno di più compassione. La maggior parte delle persone si limita a provare pietà. Quel sentimento passivo attraverso il quale si sperimenta la tristezza per chi patisce carenze, per chi lascia il proprio paese. Un sentimento provato, in particolar modo, da chi occupa il gradino più alto della società. Ma solo chi è compassionevole assume un sentimento attivo, si sforza per agire e cambiare le cose. Fa tutto il possibile per mitigare la sofferenza altrui.
Ciò che incuriosisce di più nella nostra società moderna è il grande disagio che la parola “compassione” suscita. Ad esempio, a nessuno piace essere compatito, perché in qualche modo accetta di riconoscere una posizione di debolezza, una dimensione che non ci colloca allo stesso livello di opportunità degli altri. Il significato di questo termine, però, cambia notevolmente se viene considerato all’interno della cultura buddhista.
“La pietà non costa nulla e non vale niente.”
Josh Billings
La compassione è uno strumento eccezionale che produce diversi risultati positivi. Il primo è vedere il mondo da un punto di vista più umano, affettuoso e sensibile. Inoltre, viene aggiunto l’autentico impegno di voler alleviare la sofferenza, di fare tutto il possibile per far terminare il dolore provato.
Ma esiste anche una dimensione interiore, fortemente necessaria, che è l’autocompassione. Anche in questo caso, dovremmo essere proattivi nei confronti dei nostri bisogni.
In breve, non è sufficiente, non basta provare pietà. Osservare chi soffre e mettersi nei loro panni per qualche momento, sperimentando quegli stessi dolori, per poi allontanarsi e riprendere la propria vita, dimenticando ciò che si è visto come se non fosse mai accaduto. Abbiamo bisogno di azione, volontà e impegno. Verso gli altri, ma anche verso noi stessi. Sviluppando quella realtà interiore che a volte trascuriamo e dimentichiamo.

Il mondo ha bisogno di più compassione, più impegno
Spesso ignoriamo la grande implicazione psicologica di alcuni termini. Così, la parola “pietà” si nasconde nei recessi delle sue tre sillabe, dalle dimensioni curiose quanto sorprendenti. Alcuni affermano, per esempio, che quando provano questa emozione, applicano il massimo grado di empatia. Sono in grado di connettersi alla sofferenza degli altri, riconoscendo ciò che fa male, soffrendo quasi in prima persona. Provando pietà, automaticamente consumano il loro sforzo emotivo.
Ma attenzione, “avere pietà” di qualcuno non ha nulla a che vedere con l’empatia. Dal momento che questo sentimento nasce da una sensazione di superiorità. È evidente di qualcosa che ci separa dall’altro: l’aspetto, lo status, il livello economico e anche la distanza fisica propria della specie. Per esempio, quando si prova pietà per un animale.
D’altra parte, quando si prova compassione, la parola stessa indica già una certa propensione a fare, allo sporgersi in avanti, a cercare un contatto. Questa parola deriva dal latino “cum passio” e potrebbe essere tradotta come “soffrire insieme”.
Le distanze svaniscono per stabilire una vicinanza da simile a simile, in cui si partecipa al dolore altrui, ma con uno scopo molto chiaro: impegnarsi insieme per migliorare la sua situazione. Possiamo concludere che la compassione è il risultato della confluenza di tre aspetti di base:
- Emotivo: ci uniamo attivamente alla sofferenza degli altri, sperimentando la motivazione di un cambiamento, un desiderio di intervento per generare benessere.
- Cognitivo: percepiamo il dolore degli altri e lo valutiamo, giungendo alla conclusione della necessità di sviluppare un piano d’azione.
- Comportamentale: la decisione di implementare una serie di azioni per risolvere la complicata situazione del nostri simile.
L’empatia non è sinonimo di compassione. La maggior parte delle persone si immedesima negli altri, ma solo in casi speciali questo viene accompagnato da azioni concrete. La compassione implica un sentimento dinamico, proattivo, un’azione che parte dalle emozioni ma cerca un obiettivo definito: migliorare la situazione altrui.
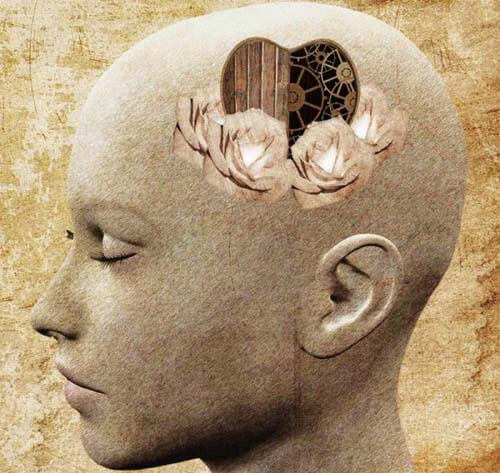
Compassione, un istinto che il mondo deve recuperare
Il mondo ha bisogno di più compassione. Sono molte le persone che contemplano il dolore degli altri, ma poche quelle che mettono a disposizione dei mezzi (i loro mezzi) per favorire un cambiamento positivo.
Come indicato all’inizio, questa parola ha ancora un’implicazione alquanto complessa e scomoda nel vocabolario umano. A nessuno piace trasmettere un sentimento di dispiacere. Il più delle volte, siamo anche riluttanti a ricevere aiuto dagli altri.
Tuttavia, come spiega uno studio dell’Università di Berkeley (California), l’uomo dovrebbe essere in grado di recuperare questo suo “istinto primario”. La compassione sarebbe quella risposta naturale e automatica che ci ha permesso di sopravvivere come specie.
È stato anche dimostrato che i bambini di 2 e 3 anni mostrano un comportamento compassionevole nei confronti dei coetanei anche in assenza di ricompense. È una reazione, un tipo di risposta istintiva. Oggi, purtroppo, la compassione tende a scomparire e spesso a causa del condizionamento e della pressione sociale.

Un dato interessante fornito dal dottor Dachner Keltner, a capo dello studio realizzato dall’Università di Berkeley, riguarda il famoso aforisma “la specie che sopravvive è quella che è in grado di adattarsi meglio”. È attribuito a Charles Darwin, eppure non sarebbe opera del famoso autore dell’Origine delle specie. Quell’idea, quella frase, fu coniata da Herbert Spencer e dai darwinisti sociali, che volevano giustificare la superiorità della classe e della razza.
Charles Darwin sottolineava un’idea ben diversa. Infatti, come lui stesso spiegava nei suoi scritti le società in cui la compassione è più accentuata godono di maggiori possibilità di evoluzione.
Queste sono le sue parole: “istinti sociali o materni come la compassione sono migliori di qualsiasi altro. Le comunità che includono un numero maggiore di membri compassionevoli prospereranno di più, perché questa caratteristica favorisce la sopravvivenza e il benessere della specie”.
Il mondo ha bisogno di più compassione. La maggior parte delle persone si limita a provare pietà. Quel sentimento passivo attraverso il quale si sperimenta la tristezza per chi patisce carenze, per chi lascia il proprio paese. Un sentimento provato, in particolar modo, da chi occupa il gradino più alto della società. Ma solo chi è compassionevole assume un sentimento attivo, si sforza per agire e cambiare le cose. Fa tutto il possibile per mitigare la sofferenza altrui.
Ciò che incuriosisce di più nella nostra società moderna è il grande disagio che la parola “compassione” suscita. Ad esempio, a nessuno piace essere compatito, perché in qualche modo accetta di riconoscere una posizione di debolezza, una dimensione che non ci colloca allo stesso livello di opportunità degli altri. Il significato di questo termine, però, cambia notevolmente se viene considerato all’interno della cultura buddhista.
“La pietà non costa nulla e non vale niente.”
Josh Billings
La compassione è uno strumento eccezionale che produce diversi risultati positivi. Il primo è vedere il mondo da un punto di vista più umano, affettuoso e sensibile. Inoltre, viene aggiunto l’autentico impegno di voler alleviare la sofferenza, di fare tutto il possibile per far terminare il dolore provato.
Ma esiste anche una dimensione interiore, fortemente necessaria, che è l’autocompassione. Anche in questo caso, dovremmo essere proattivi nei confronti dei nostri bisogni.
In breve, non è sufficiente, non basta provare pietà. Osservare chi soffre e mettersi nei loro panni per qualche momento, sperimentando quegli stessi dolori, per poi allontanarsi e riprendere la propria vita, dimenticando ciò che si è visto come se non fosse mai accaduto. Abbiamo bisogno di azione, volontà e impegno. Verso gli altri, ma anche verso noi stessi. Sviluppando quella realtà interiore che a volte trascuriamo e dimentichiamo.

Il mondo ha bisogno di più compassione, più impegno
Spesso ignoriamo la grande implicazione psicologica di alcuni termini. Così, la parola “pietà” si nasconde nei recessi delle sue tre sillabe, dalle dimensioni curiose quanto sorprendenti. Alcuni affermano, per esempio, che quando provano questa emozione, applicano il massimo grado di empatia. Sono in grado di connettersi alla sofferenza degli altri, riconoscendo ciò che fa male, soffrendo quasi in prima persona. Provando pietà, automaticamente consumano il loro sforzo emotivo.
Ma attenzione, “avere pietà” di qualcuno non ha nulla a che vedere con l’empatia. Dal momento che questo sentimento nasce da una sensazione di superiorità. È evidente di qualcosa che ci separa dall’altro: l’aspetto, lo status, il livello economico e anche la distanza fisica propria della specie. Per esempio, quando si prova pietà per un animale.
D’altra parte, quando si prova compassione, la parola stessa indica già una certa propensione a fare, allo sporgersi in avanti, a cercare un contatto. Questa parola deriva dal latino “cum passio” e potrebbe essere tradotta come “soffrire insieme”.
Le distanze svaniscono per stabilire una vicinanza da simile a simile, in cui si partecipa al dolore altrui, ma con uno scopo molto chiaro: impegnarsi insieme per migliorare la sua situazione. Possiamo concludere che la compassione è il risultato della confluenza di tre aspetti di base:
- Emotivo: ci uniamo attivamente alla sofferenza degli altri, sperimentando la motivazione di un cambiamento, un desiderio di intervento per generare benessere.
- Cognitivo: percepiamo il dolore degli altri e lo valutiamo, giungendo alla conclusione della necessità di sviluppare un piano d’azione.
- Comportamentale: la decisione di implementare una serie di azioni per risolvere la complicata situazione del nostri simile.
L’empatia non è sinonimo di compassione. La maggior parte delle persone si immedesima negli altri, ma solo in casi speciali questo viene accompagnato da azioni concrete. La compassione implica un sentimento dinamico, proattivo, un’azione che parte dalle emozioni ma cerca un obiettivo definito: migliorare la situazione altrui.
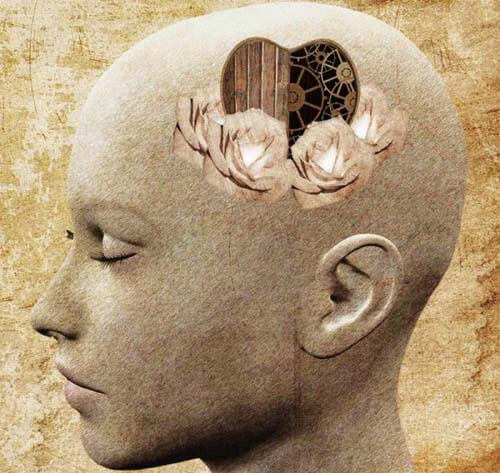
Compassione, un istinto che il mondo deve recuperare
Il mondo ha bisogno di più compassione. Sono molte le persone che contemplano il dolore degli altri, ma poche quelle che mettono a disposizione dei mezzi (i loro mezzi) per favorire un cambiamento positivo.
Come indicato all’inizio, questa parola ha ancora un’implicazione alquanto complessa e scomoda nel vocabolario umano. A nessuno piace trasmettere un sentimento di dispiacere. Il più delle volte, siamo anche riluttanti a ricevere aiuto dagli altri.
Tuttavia, come spiega uno studio dell’Università di Berkeley (California), l’uomo dovrebbe essere in grado di recuperare questo suo “istinto primario”. La compassione sarebbe quella risposta naturale e automatica che ci ha permesso di sopravvivere come specie.
È stato anche dimostrato che i bambini di 2 e 3 anni mostrano un comportamento compassionevole nei confronti dei coetanei anche in assenza di ricompense. È una reazione, un tipo di risposta istintiva. Oggi, purtroppo, la compassione tende a scomparire e spesso a causa del condizionamento e della pressione sociale.

Un dato interessante fornito dal dottor Dachner Keltner, a capo dello studio realizzato dall’Università di Berkeley, riguarda il famoso aforisma “la specie che sopravvive è quella che è in grado di adattarsi meglio”. È attribuito a Charles Darwin, eppure non sarebbe opera del famoso autore dell’Origine delle specie. Quell’idea, quella frase, fu coniata da Herbert Spencer e dai darwinisti sociali, che volevano giustificare la superiorità della classe e della razza.
Charles Darwin sottolineava un’idea ben diversa. Infatti, come lui stesso spiegava nei suoi scritti le società in cui la compassione è più accentuata godono di maggiori possibilità di evoluzione.
Queste sono le sue parole: “istinti sociali o materni come la compassione sono migliori di qualsiasi altro. Le comunità che includono un numero maggiore di membri compassionevoli prospereranno di più, perché questa caratteristica favorisce la sopravvivenza e il benessere della specie”.
Questo testo è fornito solo a scopo informativo e non sostituisce la consultazione con un professionista. In caso di dubbi, consulta il tuo specialista.







